Introduzione
L’inizio del XVIII secolo rappresenta uno spartiacque fondamentale nella storia dell’Occidente moderno. È nel cuore di questa “Età della Ragione” che si afferma la Massoneria speculativa, un fenomeno sociale e culturale che si sviluppa parallelamente ai grandi movimenti illuministi europei. Nel 1717, la fondazione della Gran Loggia di Londra segna l’avvento di una nuova organizzazione che, abbandonando progressivamente la dimensione operativa e corporativa dei muratori medievali, si apre a un pubblico più vasto di gentiluomini, intellettuali, professionisti e mercanti.

Questa evoluzione non è solo formale: le logge massoniche del Settecento diventano rapidamente centri propulsori di convivialità, fratellanza e – soprattutto – laboratori di nuove idee. L’adesione ai principi illuministi di tolleranza, progresso, centralità della ragione e libertà di coscienza si riflette nella struttura stessa della Massoneria, che si trasforma in una vera e propria scuola di civiltà laica e cosmopolita, capace di attrarre figure di primo piano del pensiero e dell’azione sociale.
Fra i grandi interpreti di questa stagione luminosa spicca Benjamin Franklin, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti d’America e protagonista della diplomazia transatlantica, che trova proprio nella Massoneria un ambiente congeniale dove esercitare e diffondere i valori dell’Illuminismo.
Nei prossimi paragrafi esploreremo le origini storiche della Massoneria illuminista, il suo ruolo nella diffusione delle idee moderne e l’influenza esercitata da massoni d’eccezione come Franklin, ricostruendo il legame profondo fra logge, filosofia dei Lumi e sviluppo della società civile.
Dalle Corporazioni Medievali alla Massoneria Speculativa
Per comprendere la natura e la portata rivoluzionaria della Massoneria illuminista, è necessario risalire alle sue radici medievali. Per secoli, l’organizzazione sociale e professionale dell’Europa era basata su corporazioni di mestiere: sodalizi di artigiani – muratori, falegnami, fabbri, panettieri – che offrivano ai propri membri protezione, formazione, reti di solidarietà e regole comuni. Tra queste, le corporazioni dei “liberi muratori” si distinguevano per il carattere itinerante e per il possesso di saperi matematici, geometrici e simbolici necessari alla costruzione di cattedrali e opere pubbliche.
L’appartenenza alla corporazione era tutelata da parole, segni e strette di mano segrete: solo chi possedeva questi “segreti” era riconosciuto come vero artigiano e poteva lavorare in città diverse. Nel corso dei secoli, però, la struttura delle corporazioni andò incontro a una progressiva crisi, sotto la spinta delle nuove condizioni economiche e della nascente società moderna.
La vera svolta avviene all’alba del XVIII secolo: mentre molte corporazioni declinano o si dissolvono, alcune logge muratorie inglesi, specialmente a Londra, iniziano ad aprire le proprie porte a membri non-artigiani – gentiluomini, scienziati, filosofi e commercianti – attratti sia dal fascino delle antiche tradizioni, sia dal clima di convivialità e di scambio intellettuale che vi si respirava.
Nel 1717, quattro logge londinesi storiche (“The Goose and Gridiron”, “The Crown”, “The Apple Tree” e “The Rummer and Grapes”) decisero di unirsi, fondando la Gran Loggia di Londra, un’istituzione destinata a coordinare e regolamentare il movimento massonico nascente che abbracciando le idee dell’Illuminismo e diventa una vera “palestra di cittadinanza” per la borghesia europea.
Questa transizione dall’operatività artigianale alla speculazione filosofica rappresenta uno dei tratti distintivi della Massoneria moderna. Non più solo costruire cattedrali di pietra, ma anche e soprattutto edificare templi interiori e sociali, attraverso il lavoro sulla conoscenza, sulla coscienza e sulla fratellanza.
La Massoneria nell’Età dei Lumi
L’affermarsi della Massoneria speculativa coincide con una delle stagioni più fertili della storia del pensiero occidentale: l’Illuminismo. Nel Settecento, le logge massoniche si trasformano rapidamente in veri laboratori del progresso, accogliendo uomini – e, in seguito, anche donne – animati dal desiderio di conoscenza, di emancipazione personale e di miglioramento sociale.
Le logge diventano spazi privilegiati di incontro fra individui di diversa estrazione sociale, in cui la discussione libera, la tolleranza religiosa, la ricerca della verità e il rispetto della ragione sono valori centrali. Qui si dibattono le grandi questioni della modernità: dalla libertà di coscienza ai diritti dell’uomo, dall’uguaglianza civile al superamento dei dogmatismi religiosi. Il simbolismo massonico, riletto in chiave razionalista, diventa strumento pedagogico ed etico più che esoterico, favorendo la crescita di una nuova coscienza civica.
Nelle logge massoniche dell’Illuminismo, si incontrano filosofi, scienziati, letterati, militari riformatori sociali e politici, accomunati dalla convinzione che la ragione e la scienza possano condurre l’umanità verso il progresso. Il clima di fraternità e di mutuo sostegno che si respira nelle riunioni favorisce la nascita di reti di solidarietà e di collaborazione, che superano i confini nazionali, religiosi e di classe.
Non a caso, molti protagonisti del pensiero illuminista europeo – da Voltaire a Montesquieu, da Lessing a Franklin – sono anche massoni, e considerano la loggia come una “società civile in miniatura”, un luogo dove sperimentare concretamente i principi della libertà, dell’uguaglianza e della fraternità. La Massoneria contribuisce così, in modo decisivo, alla circolazione e alla pratica dei valori umanisti e progressisti che caratterizzeranno l’epoca moderna.
La Diffusione Internazionale della Massoneria Illuminista
L’impatto della Massoneria illuminista non si limitò alla sola Inghilterra. Al contrario, fu la sua straordinaria capacità di diffondersi e adattarsi ai diversi contesti europei e americani a renderla un fenomeno unico nella storia delle idee. Già a partire dagli anni ’20 del Settecento, la nuova Massoneria speculativa attraversa la Manica e si stabilisce rapidamente in Francia, dove trova terreno fertile grazie alla vivacità intellettuale e all’apertura verso le nuove correnti di pensiero.
In Francia, le logge diventano veri e propri salotti dell’élite culturale e borghese, ospitando personalità di spicco come Montesquieu, Voltaire e Diderot, ma anche scienziati, magistrati, commercianti e militari. La Massoneria francese assorbe e rielabora i principi illuministi, trasformandosi in uno dei principali vettori della modernità, non solo sul piano filosofico ma anche su quello sociale e politico.
L’influenza delle logge massoniche si estende poi in tutta Europa e oltre: in Italia, in Germania, nei Paesi Bassi, in Spagna, così come nelle colonie americane, la Massoneria diventa spesso il laboratorio dove si sperimentano nuove idee di libertà, eguaglianza e fratellanza. Non è un caso che molte delle Costituzioni e delle Dichiarazioni dei diritti del Settecento – dalla Francia agli Stati Uniti – siano state ispirate da principi che circolavano nelle logge.
Negli Stati Uniti, la Massoneria accompagna la nascita della nuova nazione e si intreccia con le biografie di molti dei padri fondatori. Benjamin Franklin rappresenta il modello perfetto di “massone internazionale”: uomo di scienza, politico, diplomatico e massone attivo sia a Filadelfia che a Parigi, egli incarna la figura del “fratello cosmopolita”, capace di tessere relazioni fra mondi diversi e di portare avanti i valori della ragione, della tolleranza e della fratellanza su entrambe le sponde dell’Atlantico.
La capacità della Massoneria di adattarsi ai diversi contesti, pur mantenendo una solida base di principi universali, ne garantì la sopravvivenza e la crescita nei secoli, rendendola un punto di riferimento per tutte le anime progressiste e riformatrici dell’epoca dei Lumi.
Benjamin Franklin: Massone, Illuminista e Uomo del Mondo
Fra le grandi figure della storia massonica e dell’Illuminismo, Benjamin Franklin occupa un posto di rilievo assoluto. Nato a Boston nel 1706, Franklin fu uno dei padri fondatori degli Stati Uniti d’America, scienziato, inventore, editore, diplomatico e – non ultimo – massone convinto. La sua adesione alla Massoneria non fu solo formale: Franklin fu Maestro Venerabile della loggia “Levant Lodge” di Filadelfia e successivamente attivo nelle logge francesi durante la sua lunga permanenza a Parigi.

Per Franklin, la Massoneria rappresentò una vera e propria scuola di vita illuminista: un luogo dove discutere di scienza, etica, politica, e dove mettere in pratica i principi della ragione e della tolleranza. Egli contribuì a far sì che le logge americane diventassero centri di promozione della cultura, dell’istruzione e del progresso sociale. Fu promotore di numerose iniziative filantropiche, tra cui la fondazione della prima biblioteca pubblica e dell’Università della Pennsylvania.
Il suo ruolo di diplomatico massone fu decisivo durante la Rivoluzione Americana. A Parigi, Franklin frequentò le logge più prestigiose della capitale francese, tra cui la “Loge des Neuf Sœurs”, che annoverava tra i suoi membri filosofi e scienziati di primo piano. In queste logge si discutevano i temi della libertà, della giustizia e dell’autonomia dei popoli, in perfetta sintonia con le aspirazioni dei rivoluzionari americani. La fratellanza massonica facilitò i suoi rapporti con l’élite intellettuale e politica francese, contribuendo al successo della diplomazia americana.
Franklin seppe incarnare il massone ideale dei Lumi: uomo pratico e razionale, cosmopolita e tollerante, sempre impegnato nella costruzione di un mondo più giusto e solidale. La sua visione della Massoneria era strettamente legata all’idea di un’umanità unita da valori universali e pronta a collaborare per il bene comune, al di là delle differenze religiose, sociali o nazionali.
Benjamin Franklin: Genio dell’Illuminismo Atlantico
Benjamin Franklin (1706-1790) rappresenta una delle personalità più affascinanti e influenti dell’Illuminismo anglo-americano, esempio perfetto di quella “mobilità sociale” e di quella sete di conoscenza che caratterizzano il secolo dei Lumi. Nato a Boston in una numerosa famiglia di origini modeste, Franklin dimostrò fin da giovane una straordinaria curiosità intellettuale e una determinazione fuori dal comune. Autodidatta, iniziò la sua carriera come apprendista tipografo, per poi diventare editore, scrittore, inventore e scienziato. Le sue celebri “Poor Richard’s Almanack” diffusero massicciamente idee di buon senso, etica del lavoro e spirito comunitario tra la popolazione delle colonie americane.
Ma la fama di Franklin travalicò ben presto i confini del suo paese natale: le sue ricerche pionieristiche sull’elettricità, tra cui il famoso esperimento del parafulmine, lo consacrarono tra i principali scienziati della sua epoca, rendendolo membro di numerose accademie scientifiche europee. Oltre che scienziato, Franklin fu un grande innovatore sociale. Fu tra i primi promotori della biblioteca pubblica americana e fondò l’Università della Pennsylvania, mostrando grande attenzione all’istruzione come chiave di emancipazione e progresso collettivo. Sostenitore della solidarietà concreta, ideò società di mutuo soccorso e partecipò a iniziative filantropiche volte al miglioramento delle condizioni di vita delle classi più umili.
Il suo impegno civico si tradusse ben presto in una carriera politica di primo piano: fu uno dei principali redattori della Dichiarazione d’Indipendenza americana e svolse un ruolo cruciale come diplomatico presso la corte di Francia, diventando figura chiave nell’alleanza tra Stati Uniti e Francia durante la guerra d’indipendenza. Nella sua visione, il progresso scientifico, la tolleranza religiosa e la libertà di coscienza dovevano camminare insieme per costruire una società più giusta e razionale.
Franklin è ricordato ancora oggi come il prototipo del “self-made man” e come il simbolo del dialogo tra Europa e America, tra scienza e politica, tra ragione e filantropia. La sua eredità continua a ispirare chi crede nei valori della conoscenza, della solidarietà e della responsabilità sociale, fondamenti su cui si è sviluppata anche la moderna Massoneria speculativa.
Benjamin Franklin e la Massoneria: Una Fratellanza per il Progresso e la Ragione
La vita massonica di Benjamin Franklin rappresenta uno degli episodi più luminosi della storia della Massoneria illuminista, simbolo della sua capacità di farsi ponte tra mondi, culture e società. Franklin fu iniziato alla Massoneria nel 1731 nella loggia di Filadelfia, quando ancora la Massoneria speculativa stava consolidando la sua presenza nel continente americano, grazie all’influenza diretta delle logge inglesi. La sua adesione non fu un atto secondario o meramente sociale, ma divenne subito una scelta di campo etica e intellettuale: Franklin scelse la loggia come luogo privilegiato di incontro e di costruzione di una nuova identità civile, capace di superare le vecchie appartenenze religiose o di ceto.
La sua ascesa fu rapida e significativa: divenne Maestro Venerabile della loggia e, soprattutto, uno degli autori e diffusori delle prime “Costituzioni massoniche” pubblicate in America. Nel 1734 stampò, come editore e tipografo, la “Constitutions of the Free-Masons” di Anderson, portando per la prima volta nel continente americano il testo fondante della Massoneria moderna. Questa iniziativa non solo contribuì a diffondere i principi della Massoneria illuminista nelle colonie, ma sancì il ruolo di Franklin come punto di riferimento della Massoneria statunitense. Nelle logge di Filadelfia, Franklin mise in pratica i valori di libertà di coscienza, fraternità, tolleranza e filantropia che furono la cifra stessa del Settecento: la loggia divenne un laboratorio di democrazia e uno spazio di emancipazione dove si riunivano uomini di diversa estrazione per dibattere, imparare e cooperare, anticipando così molti dei tratti che avrebbero caratterizzato la società americana post-indipendenza.
Franklin, però, fu anche massone “cosmopolita”, capace di far dialogare mondi diversi. Durante la sua lunga permanenza a Parigi come rappresentante degli Stati Uniti presso la corte di Francia, Franklin entrò in contatto diretto con la più avanzata Massoneria europea. Frequentò la celebre Loge des Neuf Sœurs, uno dei principali epicentri dell’Illuminismo francese, punto d’incontro tra filosofi, scienziati, letterati e riformatori sociali. Qui, Franklin ritrovò lo stesso spirito di apertura, razionalità e fraternità che aveva animato la sua esperienza americana. Proprio attraverso la rete massonica riuscì a costruire legami di fiducia con molti intellettuali e uomini politici francesi, tra cui Voltaire, Condorcet e Lalande. In questi ambienti, la Massoneria non era solo un luogo di ritualità, ma un vero motore di progresso, cultura e diplomazia.
Il ruolo di Franklin nella Massoneria parigina fu duplice: da un lato contribuì a diffondere le idee della rivoluzione americana e a rafforzare l’alleanza tra Francia e Stati Uniti, dall’altro si fece portatore del metodo massonico di confronto laico, cooperazione e solidarietà. La loggia era per Franklin un laboratorio dove esercitare la tolleranza attiva e la filantropia, dove l’educazione diventava strumento di emancipazione sociale e il progresso scientifico veniva messo al servizio del bene collettivo. La sua presenza nelle logge francesi contribuì a rendere visibile, agli occhi degli europei, il modello americano di una società fondata su valori laici, democratici e pluralisti, spesso elaborati e sperimentati proprio nelle logge massoniche.
Anche dopo il ritorno in patria, Franklin continuò a sostenere l’ideale massonico come “scuola di cittadinanza”, veicolo di dialogo tra culture e classi sociali diverse. Il suo lascito fu quello di una Massoneria aperta, progressista, dinamica: un’istituzione che, grazie al contributo di uomini come lui, seppe farsi laboratorio di libertà e luogo d’incontro tra scienza, etica e politica. Non a caso, molte delle società di mutuo soccorso, delle biblioteche pubbliche, delle accademie e delle istituzioni civili sorte negli Stati Uniti portano l’impronta diretta o indiretta della sua esperienza massonica.
In conclusione, la vicenda massonica di Franklin dimostra come la Massoneria illuminista non fosse solo uno spazio di ritualità e simbolismo, ma soprattutto una comunità operativa, tesa al miglioramento umano e sociale. Franklin rimane una delle sue figure più alte: il simbolo di un uomo che, attraverso la Fratellanza massonica, seppe unire in sé l’eredità della ragione, dell’impegno civile e della solidarietà universale.
Il Contributo della Massoneria Illuminista alla Società Moderna
L’eredità della Massoneria illuminista si è tradotta in un apporto fondamentale alla costruzione della società moderna, soprattutto attraverso la promozione dei diritti umani, della libertà di coscienza e della laicità. Nelle logge settecentesche si discuteva, spesso in anticipo sui tempi, dell’eguaglianza degli uomini di fronte alla legge e dell’autonomia morale dell’individuo. Ponendo al centro la libertà di coscienza, la Massoneria divenne un laboratorio sperimentale per le idee di tolleranza e pluralismo che avrebbero ispirato le principali dichiarazioni dei diritti e le costituzioni moderne. In particolare, la laicizzazione del Rito Francese promossa dal Grand Orient de France nel 1877 sancì definitivamente il carattere progressista della Massoneria continentale, rafforzando il suo ruolo di avanguardia nella battaglia per la libertà e l’autodeterminazione dello spirito.
Fondamentale fu anche il contributo nel campo dell’educazione, della filantropia e delle scienze, secondo un modello che trova in Franklin uno dei suoi massimi interpreti. Molte logge diventarono veri e propri centri di promozione culturale e scientifica, favorendo la nascita di biblioteche, scuole, ospedali e società di mutuo soccorso. Questa vocazione alla filantropia, fondata sulla solidarietà concreta e sulla valorizzazione della conoscenza, permise alla Massoneria di essere un motore di rinnovamento sociale, orientando l’azione verso la costruzione di una società più giusta, fondata sulla ragione e sul merito e non su privilegi di nascita o appartenenza confessionale.
Non va infine dimenticato il ruolo delle logge come vere e proprie scuole di democrazia e cittadinanza. La prassi massonica del dibattito libero, della rotazione delle cariche e della partecipazione attiva alla gestione della vita associativa offrì a intere generazioni l’opportunità di sperimentare la pratica della tolleranza, della responsabilità collettiva e della costruzione del consenso. È proprio in questa dimensione, al tempo stesso etica e operativa, che la Massoneria illuminista ha lasciato la sua traccia più profonda, diventando uno dei pilastri su cui si è fondata la cultura civica delle democrazie moderne.
Eredità e Attualità della Massoneria Illuminista
L’eredità della Massoneria illuminista continua a vivere nelle logge contemporanee, soprattutto attraverso la sopravvivenza e l’attualizzazione dei suoi valori fondanti. I principi di laicità, libertà di coscienza, tolleranza, razionalità e filantropia non sono rimasti retaggio del passato, ma costituiscono ancora oggi il cuore pulsante delle pratiche e dell’identità massonica, specialmente laddove la tradizione dei Lumi è stata interiorizzata come scelta consapevole e orientamento di metodo.
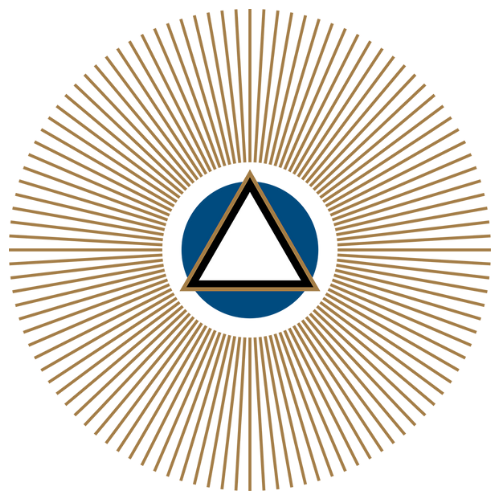
Le logge che si ispirano al filone illuminista, e in particolare al Rito Francese, continuano a promuovere una visione della Massoneria come laboratorio di pensiero libero e come palestra di cittadinanza attiva. In Italia, il Rito Francese Groussier rappresenta la declinazione più coerente e fedele di questo spirito: un modello laico-progressista che pone la centralità dell’uomo e del miglioramento sociale al di sopra di ogni dogma, promuovendo il dialogo, la critica costruttiva e il lavoro comune per una società più giusta e solidale. Il rituale Groussier, infatti, nasce come riforma interna al Rito Francese, con l’intento di restituire alla Massoneria laica europea quella “grammatica per l’azione cittadina” che la caratterizzò fin dai tempi dell’Illuminismo.
Nonostante le trasformazioni della società, le logge illuminate dal pensiero razionalista e umanista si fanno ancora portatrici di una missione attuale: coltivare il libero pensiero, difendere la libertà assoluta di coscienza, educare alla responsabilità individuale e collettiva, costruire ponti tra generazioni e culture diverse. In questo senso, la Massoneria illuminista rappresenta non solo una memoria storica, ma anche una riserva di futuro per chi crede nel valore della ragione, nel dialogo fra eguali e nell’impegno per una cittadinanza universale.
Conclusione
La storia della Massoneria illuminista e la figura di Benjamin Franklin dimostrano come le logge non siano state soltanto spazi rituali o semplici reti sociali, ma autentici laboratori di emancipazione, innovazione e dialogo. Nel cuore del Settecento, la Massoneria si fa interprete delle aspirazioni più alte della modernità: la ricerca della verità attraverso la ragione, la difesa della libertà di coscienza, l’impegno concreto per l’uguaglianza e il progresso collettivo. L’esperienza di Franklin ne è esempio luminoso: scienziato, riformatore, diplomatico, ma soprattutto massone convinto, egli incarna la possibilità di un uomo nuovo, capace di unire in sé l’azione, la riflessione e il servizio all’umanità.
L’eredità dei Lumi vive ancora oggi laddove la Massoneria si pone come scuola di cittadinanza attiva e laboratorio di tolleranza, contribuendo a costruire società più libere, giuste e aperte al confronto. In un mondo in cui le vecchie certezze vacillano e le sfide della convivenza si fanno più complesse, il richiamo alla lezione illuminista – e alla sua declinazione massonica – appare più attuale che mai.
Il Rito Francese, nella sua versione laica e progressista, e il modello Groussier rappresentano la continuità di questa tradizione: un invito permanente alla riflessione critica, alla solidarietà operativa e alla costruzione di un futuro in cui la libertà, la fraternità e la ragione non siano soltanto parole, ma strumenti vivi di trasformazione sociale.
Bibliografia
- Margaret C. Jacob, Massoneria illuminata, Einaudi, 1997.
- Gian Mario Cazzaniga (a cura di), Massoneria, Annali n. 21, Einaudi, 2006.
- Francesco Guida, IL RITO FRANCESE. Una massoneria per l’uomo e la società, Anthropolis, 2025.
