Durante la sua ammissione al grado di Maestro, il richiedente vede recitare una scena e ascolta un discorso previsto. Tuttavia, una lettura iniziatica e non più allegorica dell’omicidio di Hiram non rivela nulla di dogmatico. Al contrario, la grande figura del Maestro ci invita a definire il nostro cammino, quello che conduce al Tempio costruito.
Le culture, le correnti di pensiero, generalmente hanno una figura mitica su cui fonda, storicamente o simbolicamente, la loro esistenza: Mosè, Confucio, Gesù, Maometto, Buddha, Mao ecc. La Massoneria ha la sua figura mitica in Hiram.
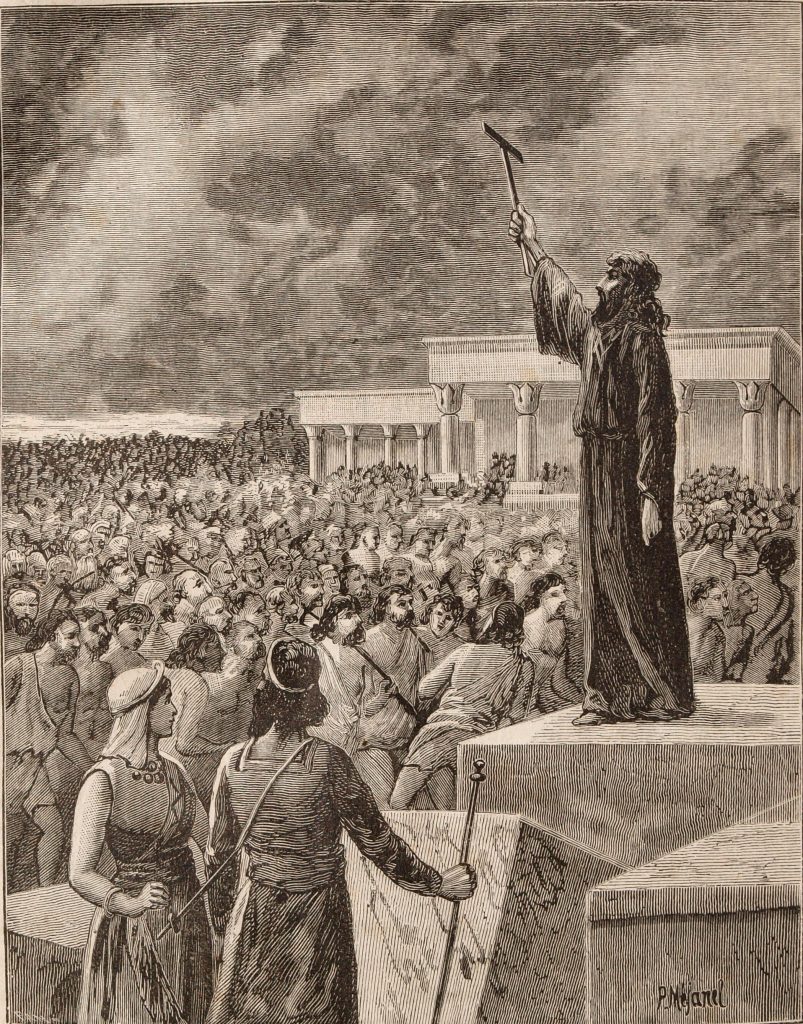
Dopo le fasi preparatorie dei gradi di Apprendista e di Compagno, col conferimento del grado di Maestro, che dovrebbe contenere la pienezza dell’esperienza massonica, viene consegnata anche la leggenda di Hiram.
Hiram è ampiamente conosciuto da tutti i massoni, e ha conquistato un posto anche nella letteratura profana, ad esempio con “La leggenda di Hiram» di Gérard de Nerval, tanto per citare uno tra i migliori riferimenti. Tuttavia, al contempo Hiram è mal conosciuto.
Il personaggio è evocato attraverso aneddoti nella Bibbia, e la storia scientifica non gli attribuisce alcuna opera degna di essere ricordata, né risultati, né un qualsiasi insegnamento. Questo è sicuro perché, in assenza di ogni certezza, gli viene talvolta attribuito una quantità di tratti della personalità, pregi, difetti, di cui dobbiamo prendere atto che non hanno alcun fondamento reale né intellettuale.
In un moderno vocabolario, Hiram è un significante, cioè una parola, un segno, che rimanda ad un significato, cioè un senso. Non è una persona, è tutt’al più un personaggio da leggenda, cioè una figura immaginaria che esiste solo nell’ambito di ciò che il suo autore gli vuol fare rappresentare. Perché un testo va interpretato non secondo i personaggi che mette in scena, ma secondo il suo autore, in questo caso la Massoneria, che nel rituale utilizza dei simboli per farci capire cosa vuole trasmetterci.
Pertanto, in Massoneria, Hiram è un simbolo, cioè una figura stilizzata che si suppone, per convenzione, dar conto di qualcosa che ha senso dentro della cultura massonica (un valore, a modello di pensiero, comportamento tipico eccetera.). Nel moderno vocabolario, Hiram è un “significante”, cioè, una parola, un segno, che rinvia a un “significato”, cioè un senso.
Abbiamo accennato alla Bibbia e alla letteratura, ma per un massone dove si può trovare Hiram? Non nei commentari che affollano le librerie nel reparto “esoterismo”, né nel reparto “religioni”, né nel reparto “sviluppo personale”, ma si può trovare nei testi in cui la Massoneria si esprime nella sua forma originaria: i suoi rituali. Bisogna esaminare il testo.
Hiram appare tre volte:
1) In una prima parte del rituale, all’inizio della cerimonia di esaltazione alla Maestranza: durante la presentazione della situazione luttuosa da parte del Maestro Venerabile al recipiendario, ci viene detto di Hiram:
- È “un grande architetto […] che sarebbe stato il precursore della Massoneria.
- “Hiram Abi, famoso architetto, fu inviato a Salomone da Hiram, re di Tiro, per dirigere i lavori del Tempio di Gerusalemme.
- Ha sotto il suo comando “un numero considerevole di operai”.
- Li divide in tre categorie: Apprendisti, Compagni, Maestri.
- Confida loro, per farsi riconoscere, parole, segni e toccamenti (“Proprio quelli che usiamo oggi”, dice il Rituale).
- Ispeziona i lavori ogni sera dopo che gli operai sono andati via.
2) NelIa seconda parte, assistiamo alla sequenza dell’omicidio, dall’incontro con cattivi compagni fino al ritrovamento di Hiram da parte dei Maestri. Qui si vede e si sente Hiram, ma per un totale di cinque risposte, nessuna delle quali è più lunga di due righe, comportando solo tre affermazioni significative.
- Ai cattivi Compagni che lo attendono in agguato: «Cosa volete? Perché non avete seguito gli altri Compagni?»
- Alla richiesta del primo Compagno, che gli vuole strappare le parole, il segno e il toccamento del Maestro: «Lo darò quando il Consiglio dei Maestri avrà deciso così.» Poi, di fronte all’insistenza dal Compagno: «No! Voi attenderete la riunione dei Maestri».
- Alla richiesta del secondo Compagno: «Sarete ricevuti tra i Maestri quando tradimento e crimine saranno vendicati».
- Al terzo Compagno: «Piuttosto la morte che violare il segreto che mi è stato dato confidato. Potete uccidermi, non mi farete tradire il mio giuramento». Poi Hiram muore.
3) In una terza ed ultima parte, dopo il sollevamento del corpo di Hiram e l’ingiunzione: «Fermatevi, Fratelli miei, mettiamo fine al nostro dolore», in cui si sente emergere una sorta di impazienza, il Maestro Venerabile indica: «È giunto il momento di spiegarvi l’insegnamento morale della leggenda di Hiram in cui tutti i maestri si riconoscono».
Quindi, il Maestro Venerabile, un po’ come una voce fuori campo, ci dice che Hiram era un uomo giusto, attaccato al suo dovere; un grande lavoratore, fertile artista, organizzatore abile e saggio che sopravvive nelle sue opere; che era pronto a ogni sacrificio piuttosto che cadere nella viltà o di venire meno al suo dovere.

Questo è tutto ciò che si dispone su Hiram nel corpus massonico.
Ciò che colpisce in questa ricognizione è di una pochezza tale che la figura centrale della Massoneria si ridurrebbe a così poca cosa. Per fortuna, il rito ci rassicura, in particolare dalla forza delle parole su Hiram perché, come già notato, c’è un insegnamento morale della leggenda di Hiram, che va spiegato.
Hiram è un uomo del dovere (parola che viene citata due volte) fino al punto di sacrificarsi piuttosto che fallire, un grande lavoratore che lascia un’opera che gli sopravvive. Insomma, un personaggio perfetto, esaltato come ideale del massone e dell’uomo al suo più alto livello; e, ovviamente, l’insegnamento morale è l’invito a perseguire questo ideale.
Il recipiendario potrebbe chiedersi se è nell’agiografia del compagno Stalin o nell’Imitazione di Gesù Cristo di La Mennais… In ogni caso, si è nella morale idealista, nel dualismo tra un’immagine pura, incontestabile e una realtà imperfetta, con un programma da svolgere: allineare la realtà con l’ideale. Ma si sa – si è sperimentato – quanto questo dualismo sia fragile e pericoloso. È fragile perché questo processo di allineamento artificiale è sempre pronto a rompersi alla prima burrasca che porta propositi virtuosi; è pericoloso perché, se necessario, quando la realtà è sbagliata, la spingiamo a forza nello schema dell’ideale, con danni considerevoli.
Sarebbe questa la Massoneria? C’è qualche dubbio! Quindi, occorre tornare al testo.
Analizzando attentamente il testo, si può osservare che include due livelli: ciò che dice il rituale e ciò che mostra il rituale.
Ciò che “dice” il rituale è questo discorso impersonale – si accennava alla voce fuori campo – che descrive chi era Hiram, quali erano le sue qualità, e che spiega cos’è l’insegnamento morale che ne deriva.
Ciò che il rituale “mostra” è la parte recitata, in cui viene presentata una situazione, una pantomima drammatica che si svolge davanti a noi. Non c’è nessun discorso sullo schermo, nessuna “spiegazione”, siamo inseriti direttamente nella scena e quindi abbiamo la libertà di interpretarla. Certamente, ci rendiamo conto che la parte recitata ha una forza d’impatto emotivo che non ha la narrazione impersonale che la circonda. Si può vederla come un punto focale, un modo per dirigere l’attenzione, per suggerire: “Questo è ciò che bisogna vedere! “. Quindi questo è l’aspetto interessante: ciò che mostra il rituale. Cosa si vede lì?
1. Hiram rappresenta innanzitutto l’ambiguità dei cattivi Compagni, che vogliono diventare Maestri. Un’aspirazione di per sé nobile, ma loro scelgono un percorso particolare per questo, un percorso diretto: carpire i codici dei Maestri piuttosto che acquisirne le qualità.
Ripetono il mito di Prometeo: rubare il fuoco agli dei. Solo che incontrano un ostacolo sulla loro strada, Hiram. A un bivio si chiude il percorso diretto e indica il percorso lungo, quella delle prove, quella dell’acquisizione delle qualità che porteranno a un riconoscimento: il percorso iniziatico. “Non rubate il fuoco degli dei, diventate uomini”, spiega loro.
Perché la relazione ha luogo se sbagliato? Perché i cattivi compagni credono che esista, da un lato, un percorso faticoso e doloroso e, d’altra parte, un percorso semplice e diretto. Ciò che fa capire il rituale, è che non c’è un percorso semplice e diretto. Questo è il significato del fallimento dei cattivi Compagni.
2. Hiram appare quindi come una figura etica, che consiste nella coerenza tra parole e azioni. Lo vediamo all’opera nel rifiuto dato ai cattivi Compagni di avere accesso alla parola di Maestro senza averne le qualità Maestro, cosa che sarebbe una contraddizione tra parole e azioni. Ma questa etica emerge con maggior vigore nella figura di Hiram, la cui morte simboleggia, non la virtù di un uomo straordinario, ma l’impossibilità di poter vivere con autenticità nell’incoerenza tra parole e azioni.
Il rituale fa morire Hiram per spiegarci che una vita contrassegnata dalla contraddizione tra le parole e le azioni non è autentica; che fa di noi, tutt’al più, dei morti viventi, cosa che è ancor peggio della morte. E poi, se il rituale avesse fatto rivelare da Hiram la parola del Maestro – un’altra variazione dell’incoerenza tra parole e azioni –, sarebbe morto simbolicamente sia come Hiram e sia come Maestro. Così, non avrebbe più potuto essere “riconosciuto come tale”. Paradossalmente sarebbe diventato, al contrario, un cattivo Compagno, senza poter risolvere la contraddizione.
Il rituale quindi ci dice che a volte è necessario morire concretamente (in misura minore: saper rinunciare a qualcosa) per affermare un’esistenza di piena integrità; al contrario, voler vivere ad ogni costo (in misura minore: voler ottenere qualcosa a tutti i costi) può portare a una morte simbolica, una morte a ciò che dà senso alla nostra esistenza.
3. Hiram appare anche come figura marginale. Se esaminiamo più da vicino il testo, soprattutto se ascoltiamo le poche frasi attribuite a Hiram, ci accorgiamo che egli non formula alcuna direttiva o affermazione normativa per altri. E’ marginale: umiltà nei confronti del Consiglio dei Maestri, rifiuto del tradimento e dell’illecito, rifugio nell’ambito ristretto che condiziona la sua esistenza. Infatti, Hiram non è affermazione, valore, dottrina, programma. È ripiego. Ripiego in se stesso nell’ambito della coerenza tra parola e azione. Ripiego per gli altri in un potente movimento del “fare posto “. Perché il gesto simbolico più grande riferito alla figura di Hiram è proprio questo: mettersi da parte per fare spazio ai Maestri che verranno.
Nel rituale, il ripiego assume tutta il suo ricco significato dando origine, a partire dal suo stesso movimento, all’esistenza degli altri, in quella che viene definita “palingenesi”.
Esistono molteplici modalità concrete di questo “mettersi da parte affinché l’altro esista”: figura massonica di apertura all’alterità, figura dell’ospitalità, figura della risoluzione del rapporto genitori-figli, figura dell’appartarsi di Dio per lasciare la libertà all’uomo ecc.
Si deve notare che il mettersi da parte di Hiram non è la dissoluzione del sé. Fare posto non significa scomparire. Inoltre, Hiram “messo da parte” rimane simboleggiato dal ramo di acacia. Da presenza direttiva diventa ripiego nel simbolo, di cui ognuno è libero di andare (o meno) a cercarne il senso.
4. Hiram appare infine come una figura della conoscenza Quando Hiram morì, la parola sacra del Maestro fu considerata perduta. Questa è la supposizione che fanno i Maestri. Questa parola – con i segni ad essa associati – viene data all’inizio nel grado di Maestro. Questo è ciò che i cattivi Compagni volevano estorcere a Hiram.
Si può considerare una confusione equiparare in generale questa parola sacra a ciò che viene definita “la parola perduta”. Tale parola non era propriamente “perduta”. Tutti i ne avevano conoscenza e ne hanno ancora dopo la morte di Hiram. Ora, si suppone che sia nota anche al di fuori dei Maestri, tra i Compagni indegni di possederla. Quindi, ha semplicemente perso valore a causa della sua divulgazione. Ecco perché è stata sostituita con una nuova.
Questa parola è la chiave per comparire formalmente come membro della categoria dei Maestri. Viene normalmente trasmessa ai Compagni meritevoli di accedere alla Maestranza, quando la camera dei Maestri lo ritiene opportuno. È una sorta di promozione, niente di più.
Di conseguenza, si deve ritenere che non sia questa la “parola perduta”, non solo perché questa parola non è mai andata perduta, ma perché qualcos’altro, di rilevante importanza, è andato effettivamente perduto con la morte di Hiram.
Per capire di cosa si tratta, bisogna ritornare alla figura di Hiram. Hiram è una figura di autorità: dirige la costruzione del Tempio. Ma questa autorità è ben distinta dai “poteri”, che sono rappresentati, invece, dal re di Tiro (l’altro Hiram), che lo manda in questo cantiere, e da Salomone, che è il committente. Hiram non ha nemmeno il potere di decidere chi sarà il Maestro, ma è il Consiglio dei Maestri a decidere. Allora da dove viene l’autorità di Hiram? Dalla sua conoscenza. Conoscenze importanti, che solo lui possiede e che fondano la sua competenza nella gestione del cantiere: una visione complessiva della costruzione del Tempio, ovvero, la conoscenza dell’arte di unire gli uomini all’interno di un mondo costituito.
La parola che è veramente andata perduta è questa conoscenza che nessuna parola o discorso “sostituito” può sostituire. La parola perduta è il progetto del Tempio, è “la chiave” dell’ordine mondiale, un’alternativa al caos.
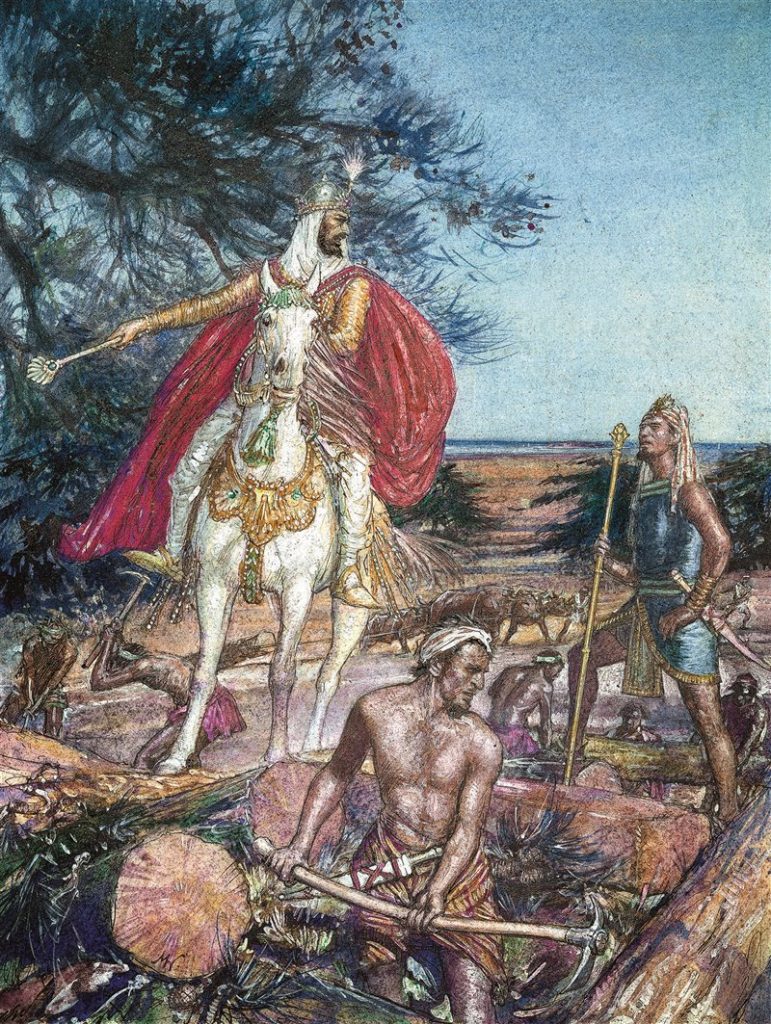
Questa conoscenza è andata perduta definitivamente con la morte di Hiram? Non proprio: l’Hiram vivente, portatore di questa conoscenza, è sostituito dal ramo di acacia, che è il segno di Hiram.
Il rituale ci fa carico di decifrare questo significante che non può scomparire, in quanto è immarcescibile, a differenza del corpo di Hiram; invita i Maestri a intraprendere questa ricerca, dando loro il punto di partenza e indicando loro come non perdersi: “Se un Maestro si perde, dove lo troveremo? – Tra la squadra e il compasso”, ovvero ritornando invariabilmente all’origine del progetto, per mettere alla prova la fedeltà del cammino intrapreso rispetto all’intenzione iniziale, onde evitare deviazioni.
In questa lettura iniziatica e non più allegorica, non appare più nulla di dogmatico nel rituale. Punto di valori esterni a sé, posti da una figura tutelare, che deve essere affrontato in un certo modo propositivo, col rischio di sbagliare – quindi sviluppare senso di colpa – e col rischio di non raggiungerlo – quindi sentirsi un fallimento. Al contrario, la grande figura di Hiram, è solo un mettersi da parte per farci spazio e un invito a definire il nostro percorso, quello che conduce al Tempio costruito, interno ed esterno.
L’iniziazione non ci dice cosa dobbiamo diventare, ma solo che dobbiamo diventare qualcosa, e che solo la ricerca della verità può portarci lì, nonostante gli ostacoli lungo il percorso.
Cosa si definisce come Hiram? Questo inizio, un desiderio che abbiamo sentito un giorno e di cui tutta la sfida della nostra vita è rimanerne fedeli. Hiram è forse il nome del nostro più bel sogno di gioventù, quando incontra il nostro primo atto di saggezza…
F.Sanchez

D’accordo sull’analisi di Hiram, cje si spiga col rituale non con voli pindarici e peggio ancora con “meditazioni” e cammino interiore perché oggi ahimè nella Massoneria sta entrando anche la massoyoga.